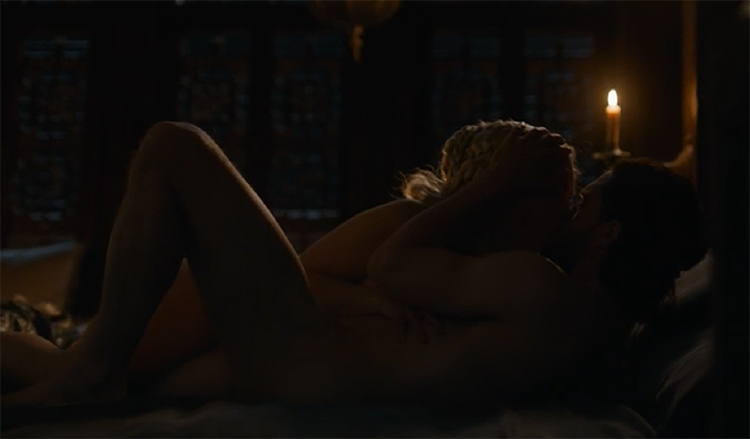Premessa: viene da se che leggere un articolo a tema Game of Thrones senza essere in pari col materiale uscito espone a dei rischi. Pare superfluo dirlo. Quello che non è superfluo, a quanto pare, è precisare che tutto ciò che riguarda possibili leak della sceneggiatura di ciò che ancora deve uscire NON è tema di discussione. Non qui sopra. Quelli sono solo SPOILER inutili che potete trovare ovunque in rete, ormai, ma che io non voglio sapere. Grazie.
Alla fine della settima stagione è tempo di rifare il punto in merito allo show che tanto sta appassionando me e larga parte delle persone che conosco. Con questi sette episodi siamo ormai davvero in dirittura d’arrivo, la storia di tutti i personaggi sta convergendo al tanto atteso gran finale e per gli show runner HBO non è stato più possibile nascondere le carte: ora sappiamo come intendono chiuderla.
Non dico a livello di trama, dove ovviamente c’è ancora più di qualche interrogativo rimasto aperto, ma a livello di approccio. Questi sette episodi ci dicono chiaramente che David Benioff e D.B. Weiss vogliono tirare tutti i fili, chiudere tutte le linee narrative che hanno aperto, con metodo e dedizione. Nessuno, credo e spero, si aspettava da loro un possibile approccio stile Lost. Lasciando da parte per un momento le opinioni personali su quel tipo di scelta narrativa, mi pare abbastanza ovvio che una risoluzione di quel tipo fosse proprio incompatibile con l’opera in questione.
Che tuttavia ci fosse così tanta attenzione a non lasciare davvero niente in sospeso non era per nulla ovvio e questa, ideologicamente, è una scelta di cui essere felici. Attenzione, io parlo dell’approccio, che è ben diverso da come questo poi viene messo in atto. Su quello, ovviamente, si può discutere.
Parliamo di Zio Benjen.*

La chiusura della storia del ranger di casa Stark credo sia senza mezzi termini il punto più basso mai raggiunto dallo show in termini di scrittura.
All’interno di un episodio già sufficientemente ricco di nonsense, la catena di eventi innescata per chiudere la storia dello zio è il picco dell’assurdo e lascia per forza di cose l’impressione di aver assistito ad una scena che aveva come unico scopo il mettere la spunta su una lista di cose da fare, più che la reale necessità di dare un epilogo al personaggio. Una cosa tipo: “Dai, e con questa anche Zio Benji ce lo siamo tolti dai coglioni”.
Possiamo ipotizzare diverse motivazioni alla base di una così brutta scelta. La prima è certamente la mancanza di tempo. La settima è a conti fatti la prima stagione di GoT in cui il numero di eventi eccede di gran lunga il tempo a disposizione. Questo si traduce in gran ritmo, ma anche in grossi sacrifici narrativi di cui Benjen è chiaro esempio. In altri casi, come quello di Nymeria, ci è andata meglio.
Ritenendo da sempre il detto “do or do not, there is no try” una cagata, continuo sulla linea di chi apprezza il tentativo degli sceneggiatori di chiudere tutto senza dimenticanze, anche quando il risultato non è soddisfacente.
La seconda cosa che questa stagione ci dice è che la conclusione sarà con ogni probabilità vicina alle aspettative dello spettatore. Non in termini di qualità o soddisfazione, ma proprio in termini di trama. Molti usano il termine “prevedibile” per definire la questione, ma per me la cosa è un po’ più complessa di così. Prima di infervorarmi quindi metto un’immagine che riassume il concetto.
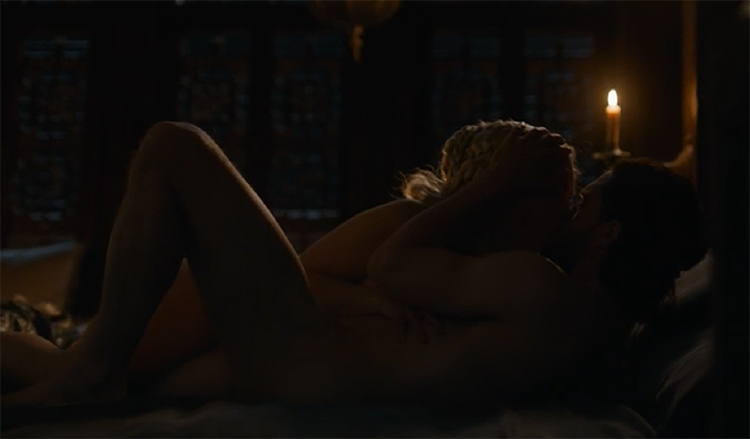
Game of Thrones nasce da una saga di romanzi fantasy e fin qui ci siamo.
In questo tipo di opere è fondamentale un’unico aspetto: la coerenza. Una volta completa, l’opera deve poter filare via liscia e ogni evento deve essere conseguenza plausibile e sensata dell’evento precedente. Nessuno parte a guardare il Signore degli Anelli pensando che Frodo alla fine non riesca a distruggere l’anello, il punto è capire come possa farcela e, soprattutto, non avere mai la percezione dell’esito scontato mentre si guarda/legge. In questo le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, sia in versione cartacea che televisiva, hanno saputo portare il senso di sospensione a livelli mai visti, inculcando nella testa dello spettatore la percezione per cui tutto sarebbe potuto succedere, ma è da sempre un bluff. Ben costruito, magistrale in certi punti, ma pur sempre un bluff.
Che l’epilogo avrebbe riguardato Jon e Dany non è mai stato in discussione. Jon è RISORTO, manco la morte può fermarlo. Se ancora pensiamo che non sia scontato il suo arrivo in fondo è perchè siamo stati distratti per anni. La grandezza di quest’opera è stata portarci dove siamo ora, ovvero dove sapevamo saremmo finiti, senza che che ne accorgessimo. Mentre noi prestavamo attenzione ai vari specchietti che ci venivano messi di fronte episodio dopo episodio, loro avanzavano, lenti, ma inesorabili, verso la conclusione.
Ora che ci siamo però, che le strade convergono, è normale che sia più difficile perdere di vista l’arrivo e, di conseguenza, non pensare al fatto che fosse chiaro fin da subito.
Un buon finale non è quindi quello che sorprende, ma quello coerente con quanto visto. Dopo sette anni siamo così dentro la vicenda, abbiamo così tante informazioni, da poter unire da soli i tasselli mancanti seguendo la logica. E’ come un puzzle, meno pezzi mancano alla fine più è facile inserirli. Non dico che sorprendere lo spettatore a questo punto sia impossibile, dico che farlo senza venir meno alla linearità della storia è difficile. Preferisco un epilogo prevedibile, ma sensato, ad uno imprevedibile che però non abbia reali basi in quanto costruito.
Dany sarebbe potuta naufragare con la flotta e non approdare mai a Westeros. Sarebbe stato sorprendente, certo, ma davvero la sorpresa è tutto ciò che abbiamo da chiedere?
Questo è quello che ha fregato Martin nei libri. Non ha accettato che il suo pubblico avesse dedotto la svolta narrativa più importante (Aegon Targaryen) e ha provato a barare, venendo meno alla coerenza fino a lì costruita. Nella serie, almeno da questo punto di vista, sono stati più bravi.
Che Jon e Dany fossero destinati ad essere gli eroi vittoriosi della storia non implica certo che finissero a letto insieme, ovviamente. Moltissimi hanno trovato scontato questo dettaglio che ai fini della storia non dovrebbe essere troppo rilevante** e che quindi sarebbe potuto tranquillamente essere evitato. Questa credo sia questione essenzialmente di gusto: c’è chi aspettava questa love story da sempre e chi sperava di non vederla mai, ci sta tutto. Io non ci vado matto, ma non stride per nulla nè con la storia, nè con la caratterizzazione dei due personaggi. A Roma credo direbbero “stacce”.
A conti fatti quindi questa non è stata certo la miglior stagione di GoT, il picco credo rimarrà la stagione scorsa, però al netto di evidenti problemi di rapporto tra numero di eventi e minuti a disposizione io sono soddisfatto.
Chiudo quindi con alcune note sparse più legate alla sostanza, a ciò che mi è piaciuto e agli interrogativi che mi sono rimasti.
Partiamo da Jaime.

L’unica cosa che ho sempre rimpianto dei libri, in termini di trasposizione on screen, è la caratterizzazione di Jaime.
Il grosso vantaggio della versione cartacea però è la narrazione a POV, che permette di farti vedere il personaggio per lungo tempo solo attraverso gli occhi di chi lo circonda, quindi per come appare, e solo poi attraverso i suoi, ovvero per ciò che è. Questo facilita molto il processo di “redenzione” perchè le ragioni che lo muovono emergono solo in seguito e portano il lettore a cambiare prospettiva. Nella serie, per ovvi motivi, questa operazione non è possibile e quindi il tutto ne esce drasticamente smorzato. Se ci aggiungiamo momenti di buio in cui gli sceneggiatori non sapevano letteralmente cosa fargli fare (ricordate “Jaime e Bronn vanno a Dorne”? Io purtroppo sì.), il timore che finisse sacrificato in toto era più che tangibile ed invece questa stagione ne determina per la prima volta il peso, mostrando Jaime per l’uomo che è e consegnandolo quindi agli spettatori come l’unico Lannister con una reale evoluzione.
La scena di lui che se ne va con la neve che arriva a King’s Landing per me in assoluto tra le migliori scene di sempre.
Una cosa che mi ha deluso, perchè ci riponevo discrete aspettative, è il rientro di Gendry che, salvo smentite future, al momento finisce nel tritacarne delle pedine sacrificate all’altare del “facciamo succedere le cose”. Fin dai tempi in cui ero semplice lettore, io sono stato #TeamBaratheon. Mi piaceva King Robert e sono tutt’ora convinto che morte di Renly sia stata la più grande porcheria della saga, in termini proprio di scrittura. Speravo quindi che il ritorno di Gendry riportasse in alto la mia casata del cuore e, devo dire, alla fine del quinto episodio ero fomentato come un bambino. Peccato la cosa si sia risolta in niente, mi auguro solo non riprendano in mano il personaggio giusto per la battaglia finale.
#MakeBaratheonGreatAgain.
Per chiudere, la morte di Viserion ed il suo arruolamento tra le fila dell’esercito degli zombie per me segna il punto chiave della divergenza tra libri e show televisivo. Se mai l’opera letteraria avrà una conclusione (cosa per nulla scontata), non credo conterrà questa svolta.
La teoria vuole che i Targaryen siano tre: Jon, Dany e Tyrion. Il drago con tre teste, ecc. Martin credo si sia tenuto il terzo in esclusiva per i libri, rendendo quindi “inutile” uno dei tre draghi. La mia speculazione vuole che il ritardo mostruoso nella messa in onda dell’ottava stagione (si parla di 2019***) sia in accordo con lo “scrittore” (virgolettato perchè uno scrittore di norma scrive): gli si da il tempo di uscire con un nuovo libro prima della conclusione della serie TV. Il libro introdurrà queste differenze in modo da tenere vivo l’interesse per la saga letteraria anche dopo la conclusione dello show, che altrimenti credo ne limerebbe non poco le aspettative ed i conseguenti profitti.
E’ un’ipotesi sensata, ma avendo a che fare con Martin può tranquillamente succedere che l’ottava stagione venga posticipata e lui non esca comunque in tempo col libro. Ormai non credo di avere più parole per esprimere il mio disprezzo nei suoi confronti, quindi la cosa mi tocca il giusto.
La serie TV avrà un finale, presto o tardi.
Io sono a posto così.
* Ho iniziato un processo di self training per iniziare ad usare ZIO BENJEN come nuova imprecazione/intercalare.
** La possibilità nasca un erede dall’unione tra Dany e Jon non la considero proprio perchè a mio avviso minerebbe la coerenza della storia. No dai, Zio Benjen, non scherziamo.
*** ZIO BENJEN!