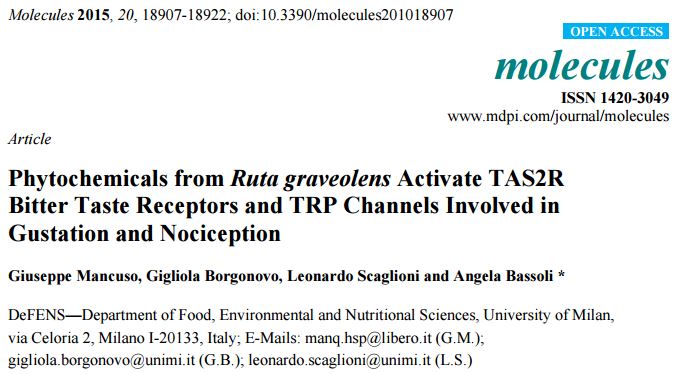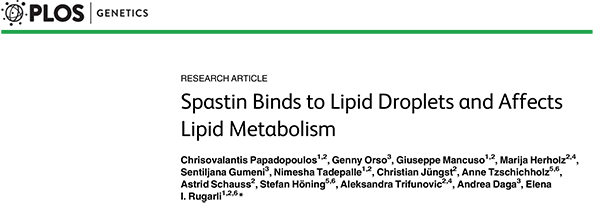Delle cose brutte della rete ho appena parlato. Nel dettaglio, la cosa brutta dei social è che c’è sempre qualcuno che ti mette a conoscenza di contenuti che avresti fatto volentieri a meno di leggere (grazie eh.). Questo è un problema, perchè quando leggo qualcosa che mi da fastidio in rete, io ho questa irrefrenabile necessità di rispondere a tono. Questa volta, tuttavia, rispondere all’articolo a tema Giochi di Ruolo di Massimo Montani e Gilberto Gerra in un commento sul loro sito mi sembrava onestamente troppo poco. La questione richiede infatti un’analisi un po’ più dettagliata e credo che questo spazio abbia ancora un senso per questo genere di operazioni.
Innanzi tutto però, ci vuole un link all’articolo che mi appresto a commentare: eccolo.
So cosa state pensando. L’ho pensato anche io. “Eh, vabbeh, ma hai visto il sito? Papaboys.org… Dai… non vale manco la pena star li a perderci tempo…”. Questo però è un commento non solo molto superficiale, ma anche dannoso, perchè sottostimare il nemico è sempre la prima causa delle sconfitte. Quindi adesso mi metto sotto e commento il pezzo in questione in maniera seria e possibilmente precisa, cercando di non cedere a facili ironie e di non buttarla troppo in caciara.
“L’espansione della pratica dei giochi di ruolo ha sollevato da più parti perplessità e allarme: l’ambientazione spesso irreale o truculenta, il carattere totalizzante e la lunga durata di questi “giochi ” porterebbe a fenomeni di alienazione e dipendenza fra i praticanti. L’articolo che segue prende dettagliatamente in esame il rischio reale.”
Come sarebbe sempre auspicabile per chi si prefigge di scrivere un testo informativo/divulgativo non ascrivibile alla sfera delle mere opinioni personali, sarebbe buona cosa indicare delle fonti. Vorrei sapere questo sollevamento da più parti di che parti è composto, ad esempio, come capire chi abbia teorizzato la connessione tra GdR e fenomeni di dipendenza e alienazione.
“La diffusione del “giochi dl ruolo” tra gli adolescenti, nell’età della difficile ricerca personale, è estremamente preoccupante e dovrebbe suscitare interrogativi non banali negli adulti. L’impiego di questo materiale riguarda un gran numero di giovani, a diversi livelli di coinvolgimento psichico ed emozionale, con conseguenze sul comportamento che non è semplice valutare.”
Io su questo posso pure essere d’accordo. Non condivido l’assunto, ma non trovo mai sbagliato che un genitore si interessi alle pratiche del figlio ed è proprio per questo che articoli come quello che sto commentando sono molto pericolosi, perchè non aiutano un genitore a capire. In effetti non è quello lo scopo. Un genitore che voglia davvero approfondire di cosa si tratti quando si parla di GdR non credo possa prendere in considerazione articoli senza fonti che spacciano per assodate teorie tutt’altro che dimostrabili. E’ più facile però che il pezzo trovi terreno fertile in chi non ha per niente voglia di capire, ma cerchi un’opinione preconfezionata da fare propria in merito per porsi poi di conseguenza nei confronti dei figli. Un nuovo dogma fatto per gente che ragiona per dogmi. Se scrivessi che avere genitori così è molto più dannoso di qualsiasi pratica GdR e che le cause di eventuali disturbi relazionali e/o tossicodipendenze andrebbero ricercate in quello, ma non avessi fonti a supporto della mia teoria, questa resterebbe mia personale opinione. Capito come funziona?
“Certo non è sensato liquidare il problema sbrigativamente, considerando questa, al pari di altre, la moda legata ad una effimera sottocultura: troppo evidente è la difficoltà degli adolescenti del nostro tempo a pensare un proprio futuro, a riconoscere la propria identità sostanziale, a polarizzare l’esistenza rispetto ai sistemi dei valori, per sottovalutare strumenti “ricreazionali” che proprio con l’identità inducono a giocare.
E ancora la diffusione di disordini psicologici e comportamentali che includono la ricerca delle “sensazioni forti”, al di fuori di un quotidiano grigio, la incapacità a distinguere tra reale e virtuale, la povertà di percezione e comunicazione delle emozioni suggeriscono la possibile corrispondenza ambigua di questi “giochi alle patologie sociali emergenti.”
Come detto all’inizio, “liquidare il problema sbrigativamente” è proprio l’errore che non voglio commettere. Di questo paragrafo, che non fa che ribadire quanto già detto e quindi non necessita particolari commenti, mi soffermerei sull’associazione del GdR alla ricerca di “Sensazioni forti”. Devo riconoscere che il nesso mi è completamente oscuro, quindi mi piacerebbe avere una spiegazione. Stiamo dicendo che un adolescente in cerca di sensazioni forti, nel 2014, sceglierebbe di sedersi ad un tavolo con degli amici ed usare la fantasia?
“L’ambientazione dei giochi include, nella migliore delle ipotesi, il mondo magico, del mistero, pieno di incantesimi, maghi, fate, elfi, guerrieri mitici; tematica classica lo scontro tra il guerriero buono e il potente malvagio: l’adolescente respira una mentalità fatta di destini ineluttabili e di insormontabili maledizioni, si immedesima in una cornice piena di ultra-poteri e di mitologie che pongono ristretti limiti alla libertà della persona.
Nei casi peggiori, e molto frequenti, l’ambiente dei giochi è quello dei mostri, dei vampiri, dell’horror più cruento, dell’occulto e dei riti iniziatici. Si va dagli amuleti stregati all’immedesimarsi nel divorare carogne e al rivivere di cadaveri: un supermercato del sacro, dell’”aldilà” e del sacro-satanico non lontano dal modo di pensare che conduce ad aderire a gruppi o sette di questo settore.”
Sarebbe facile fare dell’ironia e sottolineare che nel leggere di “destini ineluttabili e insormontabili maledizioni” la prima cosa che mi è venuta in mente è il peccato originale. Così come leggendo di “cornici piene di ultra-poteri e di mitologie” è impossibile non pensare alla Bibbia. L’idea però è di tenere il discorso su toni civili. Mi fa riflettere l’idea che per qualcuno “ristretti limiti alla libertà dell’uomo” possa avere connotazione negativa anche solo nell’ambito dell’immaginario. Inoltre, continuo a non capire su che base la finzione e l’immaginazione possano aprire le porte a certe derive in assenza di una predisposizione psicologica dell’individuo stesso. Mi si spieghi, magari con delle evidenze scientifiche a supporto.
“Il bravo giocatore è quello che sa immedesimarsi meglio nel ruolo prescelto o assegnato; viene molto apprezzato per le soluzioni intelligenti, per le risorse personali che sa tirare fuori per districarsi nei passaggi più difficili del gioco: i giochi di ruolo sono per gente “smart”, intelligente, brillante, astuta che guarda dall’alto in basso chi si accontenta degli spaghetti, della fidanzata e della vita reale: un cimento per uomini un pò “superiori”, o che comunque presto nel gruppo stabiliranno una gerarchia di “superiorità” in base alle capacità e all’intuito. Si afferma così l’atteggiamento mentale che, attraverso un “cammino di perfezionamento”, consentirebbe alla persona di raggiungere grandi risultati, ignorando limiti e relazioni interpersonali: è l’ottica utilizzata nei percorsi delle sette del “potenziale umano”.”
Lo ammetto, qui ho riso. Per tutto il mondo il giocatore di ruolo è, essenzialmente, uno sfigato. E’ uno stereotipo odioso, ma basato su una casistica di “nerd” anni ’80/’90 indiscutibilmente rilevante. Lo so perchè è un mondo che conosco bene e che ho frequentato a lungo. Credo questa sia l’unica volta in cui leggo che i giocatori di ruolo in realtà sono, parafrasando, gente smart che se la mena e taccia di inferiorità i ragazzi “normali”. Mi sembra una fotografia talmente fuori fuoco della questione, da pensare che l’articolo tutto sia in realtà una sonora presa in giro. Purtroppo non lo è. Ancora una volta, resto sbigottito nel leggere che il concetto di “cammino di perfezionamento che consente alla persona di raggiungere grandi risultati” sia un qualcosa di diseducativo. Va detto che ignoro cosa siano “le sette del potenziale umano”.
“Il fatto più inquietante è che la metodologia di tali giochi presenta forti assonanze e probabilmente una origine comune con modalità utilizzate all’interno di particolari forme di psicoterapia di gruppo: in questo ambito il terapeuta, conducendo il gruppo utilizza l’assunzione di ruoli per i pazienti, al fine di far emergere aspetti interiori inespressi, facilitare l’introspezione, rimuovere inibizioni, suggerire strategie di cura e ottenere effetti catartici.
Diviene impensabile che strumenti così delicati, utilizzati da terapeuti abilitati, nei limiti di ben precisi vincoli deontologici, e con competenze specifiche, vengano impiegati in modo aspecifico, dati in pasto, attraverso dettagliatissimi “manuali”, a chiunque li acquisti.”
Insisto imperterrito a prendere sul serio il testo e rispondere nel merito, pur iniziando a fare fatica. L’idea di base è che siccome esistono le auto di F1 e che per guidare le auto di F1 bisogna essere piloti esperti, dovrebbe essere vietato vendere le automobili comuni.
“Il leader naturale di un gruppo dl adolescenti verrà dotato, attraverso il gioco, di approfonditi elementi metodologici per indurre altri nei ruoli previsti dal gioco stesso: il manuale gli suggerisce tutti i fattori necessari, gli atteggiamenti, i comportamenti, il modo di sentire e di pensare: le sue capacità carismatiche verranno ampliate da questa “dotazione” senza che alcun riferimento etico sia garantito: si vede con facilità il rischio dell’ instaurarsi di dipendenze e sudditanze, di prevaricazioni e strumentalizzazioni che esulano dalle normali dinamiche di un gruppo adolescenziale.”
Io non lo vedo con facilità. Seriamente. Vorrei mi si spiegasse il concetto in maniera più chiara perchè così scritto non ne capisco il senso.
“La cosa diviene ancor più seria se si considerano i tempi del gioco: non si tratta di incarnare il ruolo di un personaggio fantastico per una o due sere, ma per molti mesi di seguito: occorre immaginare come ci si sente rivestendo il carattere del killer, del vampiro, della vittima, dell’ impiccato o dell’oste menzognero per 12 – 18 mesi.
“Il gioco migliore – ci ha detto con entusiasmo uno dei giovani coinvolti – è quello che non finisce mai, che dura tutta la vita” : un immedesimarsi che sostituisce irreversibilmente il ruolo fittizio e condizionato alla persona e alle sue scelte.”
Cerchiamo di capirci. 12-18 mesi è una tempistica data da chi? Su che base? Ci sono ragazzi che giocano a GdR per 12 mesi consecutivamente senza interrompere? Se ci sono pause, di quanto sono? Con che cadenza avvengono le sessioni di gioco e quanto durano? Non vi sembra di buttare lì numeri e dati senza il minimo raziocinio? Mi piacerebbe anche sapere chi sono i “giovani coinvolti” interpellati da chi scrive, perchè ho la sensazione, il dubbio anzi, che le loro parole siano state stravolte o perlomeno reinterpretate.
“Il leader del gruppo diviene un “master”, un coordinatore-facilitatore che ha il compito di condurre il gioco: di solito personalità “dominanti”, ad elevata autostima, forte determinazione, spunti di tipo narcisistico-istrionico assumono il ruolo di master; questi soggetti tradiscono una forte aggressività rivolta verso gli altri, ma la capacità di controllare i pari senza prevaricazioni aperte o cruente.
I soggetti alla ricerca di identità, piu attratti da prospettive ideali, che trovano disattese nella società reale, con caratteri di fondo non lontani dal pattern depressivo, o con personalità passivo-dipendente, si adattano al ruolo di giocatore e ricevono punto per punto dal manuale le informazioni necessarie alla definizione di sè: come devono essere “fisicamente”, come sentirsi psicologicarnente, quali atteggiamenti assumere: un vero e proprio stato di dipendenza può instaurarsi nei confronti del master: “Tutto dipende dalla bravura del master – ammette un giocatore di diciotto anni – se ci sa fare il gioco diventa straordinario” ; il ritorno ad una realtà senza ruoli predefiniti e senza guida può essere disorientante.”
Forse ho capito dove sta il problema. Non c’è malafede. Gli autori presuppongono un approccio al GdR simile a quello che loro, presumibilmente, hanno nei confronti della religione. Qui ad esempio parlano del Master come fosse un prete, ma soprattutto nel secondo paragrafo descrivono come si possa trovare nel GdR, a detta loro, quello che dovrebbe invece fornire la religione. Risposte e speranze che sono disattese dalla vita reale. Sì al regno dei cieli, no ai Forgotten Realms. Se letta così, allora tutta questa operazione ha certamente più senso. Restando sbagliata, ben inteso. Io non discuto ci sia chi ha bisogno di trovare alternative irreali alla propria esistenza per poter vivere sereno, ma a questo punto il problema è questo tipo di approccio, non la risposta che si sceglie nel perseguirlo. Chi si abbandonasse alla fede nel modo in cui loro presuppongono ci si debba abbandonare al gioco, è forse meno preoccupante? Non direi.
“Il master racconta: è la voce fuori campo, il filo conduttore, il narratore, tra le pagine di un libro, che dà colore agli avvenimenti, ai luoghi, ti fa entrare nelle situazioni. Può essere più o meno direttivo, svolgere il ruolo di un semplice “facilitatore” o suggerire con autorità incondizionata il canovaccio su cui i giocatori costruiscono la loro parte.
Permette di scegliere i personaggi o li assegna a seconda delle caratteristiche dei giocatori: anche in questo caso un ambito ricreazionale di apparente libertà si trasforma in luogo di stigmatizzazione, nell’assegnazione di “etichette” che, della persona, pretendono di esaurire le potenzialità in modo rigido e riduttivo.”
Siamo sempre lì. E’ ovvio che chi scrive presuppone un’apertura mentale nulla di chi gioca che probabilmente gli è propria.
“Il gioco è tutto mentale, non fisico, non agito: le paure o l’impatto con la concretezza, con la vita misurabile, con “l’alterità” degli altri senza mediazioni sono rimandati a un futuro senza definizione; il virtuale fa da ricettacolo per la sensazione di inadeguatezza a relazioni interpersonali “vere”‘, fatte anche di accettazione dei propri limiti e dei problemi degli altri.
Le conseguenze di quest’immersione nel virtuale, che si estendono alla vita di tutti i giorni, hanno proporzioni non valutabili. I rapporti sessuali al di fuori della coppia stabile sono liberati da “fastidiosi sensi di colpa” se avvengono in conseguenza dell’assunzione di un ruolo per gioco: la violenza o i comportamenti autodistruttivi non sei tu che li agisci, ma il tuo personaggio che ti è rimasto “appiccicato” addosso, quindi sono resi più giustificabili.”
Immagino che in altro articolo i due autori illustrino le deviazioni mentali di chi, per lavoro, fa l’attore. Oppure che combattano una lotta contro l’insegnamento della recitazione o del teatro nelle scuole. Basta recite negli asili. Basta rappresentazioni della natività in Piazza a Natale. Ok, sto sconfinando nel sarcasmo, chiedo scusa.
“Il gioco “Vampire”, ambientato tra creature della notte, non-morti o morti-viventi, definisce del vampiro i caratteri fisici, psicologici, attitudinali, “vampirici” e gli ultra-poteri: pregi e difetti del personaggio che emergeranno nelle varie partite e che consentiranno l’assegnazione di punteggi negativi o positivi.
Un pregio del vampiro proposto agli adolescenti è l’inappagabile desiderio di uccidere, un’altra caratteristica presentata come positiva è la “duplice natura”, la natura ambigua della creatura vampirica, divisa in se stessa. Un tipico difetto del vampiro è rappresentato dagli incubi notturni che lasciano strascichi la notte successiva rendendo più difficili le azioni nel gioco: non si richiede la competenza dello psichiatra per comprendere a quali gravi forme di destrutturazione della personalità ci si possa trovare di fronte in seguito a queste “innocue assunzioni di ruolo; quali percezioni distorte di sè possano essere indotte.”
Dissento. Per ipotizzare “gravi forme di destrutturazione della personalità” conseguenti al gioco di ruolo servirebbe, quantomeno, la competenza di uno psichiatra. Per fare una diagnosi, a casa mia, serve il dottore.
“Se da un lato la violenza e l’ambiguità, il sangue e l’onnipotenza sono i fattori determinanti comuni di queste trame, dall’altro una vera e propria esplicitata intenzione all’esplorazione dell’insight, del sè profondo, è oggetto di specifici glochi.
Sul gioco Kult c’è scritto: “Pericoloso: questo gioco conduce ad esplorare aspetti oscuri della tua anima; questo può arrecare disturbo a qualcuno: vietato ai minori di anni 16″ : quale sia la finalità di sintetizzare aspetti profondi di sè all’interno di un gioco non è facile intuire: certo l’aspettativa di un feeling interpersonale non superficiale, nelle dinamiche di gruppo, si va affermando sempre più e la stessa aspettativa è espressa dai consumatori di pastiglie nelle discoteche, i derivati anfetaminici definiti, proprio per il loro ruolo “‘entactogeni”.
Questo conoscersi fino in fondo ed esprimere agli altri la propria identità sostanziale risponde da un lato ad una esigenza positiva, ma c’è da chiedersi come mai debba essere mediato, nel nostro tempo, dal gioco o dai farmaci: ancora ci si deve interrogare riguardo ai limiti e alle violazioni degli stessi nell’ambito di una strumentale “divulgazione”‘ della propria intimità.”
Non conosco il gioco in questione e non ho capito grossomodo nulla del paragrafo, ivi compresa la conclusione per cui giocare di ruolo sia assimilabile all’assunzione di sostanze psicotrope.
““Ah, certo” – dice il commerciante – “Se poi qualcuno ha difficoltà personali, e interpreta le cose in modo autodistruttivo, non dipende certo dal gioco” : anche in questo caso la società adulta abdica alla responsabilità di tutelare proprio le persone più fragili… Un mondo di gente “‘solida” e sicura che prevede di generare per certo figli stabili e incondizionati: un mondo di “vincitori” che non hanno tempo per i perdenti e i falliti!”
Condivido il presupposto. E’ giusto, a mio avviso, tutelare chi non ha piena comprensione di un mezzo ed è nelle condizioni di utilizzarlo. Ben venga l’affiancamento della famiglia che si avvicina al figlio, sapendo che gioca di ruolo, e cercha di capire di cosa si tratti. Dialogo. Mi viene in mente mia madre che, quando a 15 anni ho comprato “Punk in Drublic”, si è interessata agli aspetti che potesse comportare per me ascoltare un certo genere di musica. La trovo un’operazione giusta. Meno giusto sarebbe stato dirmi: “tu quella roba non la ascolti perchè poi diventi un drogato.” Cosa che, incredibile a dirsi, non è successa.
“Da ultimo va rilevato che l’impiego di sostanze psicoattive, in particolare le metamfetamine e le incontrollabili nuove generazioni di stimolanti sintetici, si sposa perfettamente con le esigenze dei partecipanti al giochi di ruolo: queste droghe aumentano, durante l’effetto acuto, l’energia, l’intuito e la concentrazione, ma contemporaneamente conferiscono disinibizione associata ad un blando distacco dalla realtà: niente di meglio come veicolo per migliori livelli di immedesimazione nel ruolo fantastico, per affievolire ancor più i confini tra verità e sogno, nella apparente valorizzazione della propria “smartness” (lucidità, intelligenza). E, d’altro canto, proprio le alterazioni biochimiche cerebrali indotte dall’ecstasy e dalle droghe analoghe, con le associate turbe del tono dell’umore e dell’identità, potranno, all’interno di un circolo vizioso, indurre di nuovo alla dipendenza da relazioni interpersonali esclusivamente inquadrate attraverso le regole dei giochi di ruolo.”
Ecco, appunto. Quest’ultimo passaggio è estremamente debole e appare, ai miei occhi, come un tentativo ultimo di dare motivo di preoccupazione: della serie, se non è bastato tutto quello che ho detto fino ad ora (e, con ogni probabilità, non è bastato) estraggo l’anatema della droga così da fornire una preoccupazione seria e reale. Una cosa che, anche solo nel dubbio, possa centrare l’obbiettivo. Il punto è che non c’è davvero un senso logico a quanto scritto, oltre che nessuna prova empirica o ricerca scientifica a suffragare l’ipotesi. Se mi drogo per alterare la percezione di me stesso, le mie inibizioni, e la mia realtà, perchè farlo in concomitanza ad uno svago dove tutto questo posso ottenerlo senza droga? Anche solo economicamente, non è una scelta furba. Mi drogherò in discoteca, ai concerti, a scuola, sul lavoro, in famiglia, ovunque non abbia altro mezzo per non essere me stesso. Magari però è a me che manca qualche passaggio.
Se mi sono preso tutto questo tempo (ciao pausa pranzo) e questi caratteri per rispondere all’articolo è perchè come detto trovo sbagliato lasciar correre operazioni come quella messa in atto dal pezzo in questione.
La speranza è quella di alimentare discussione, confronto e scambio di opinioni (perchè di quello si tratta). Una cosa che, da sempre, ritengo utile a tutti.