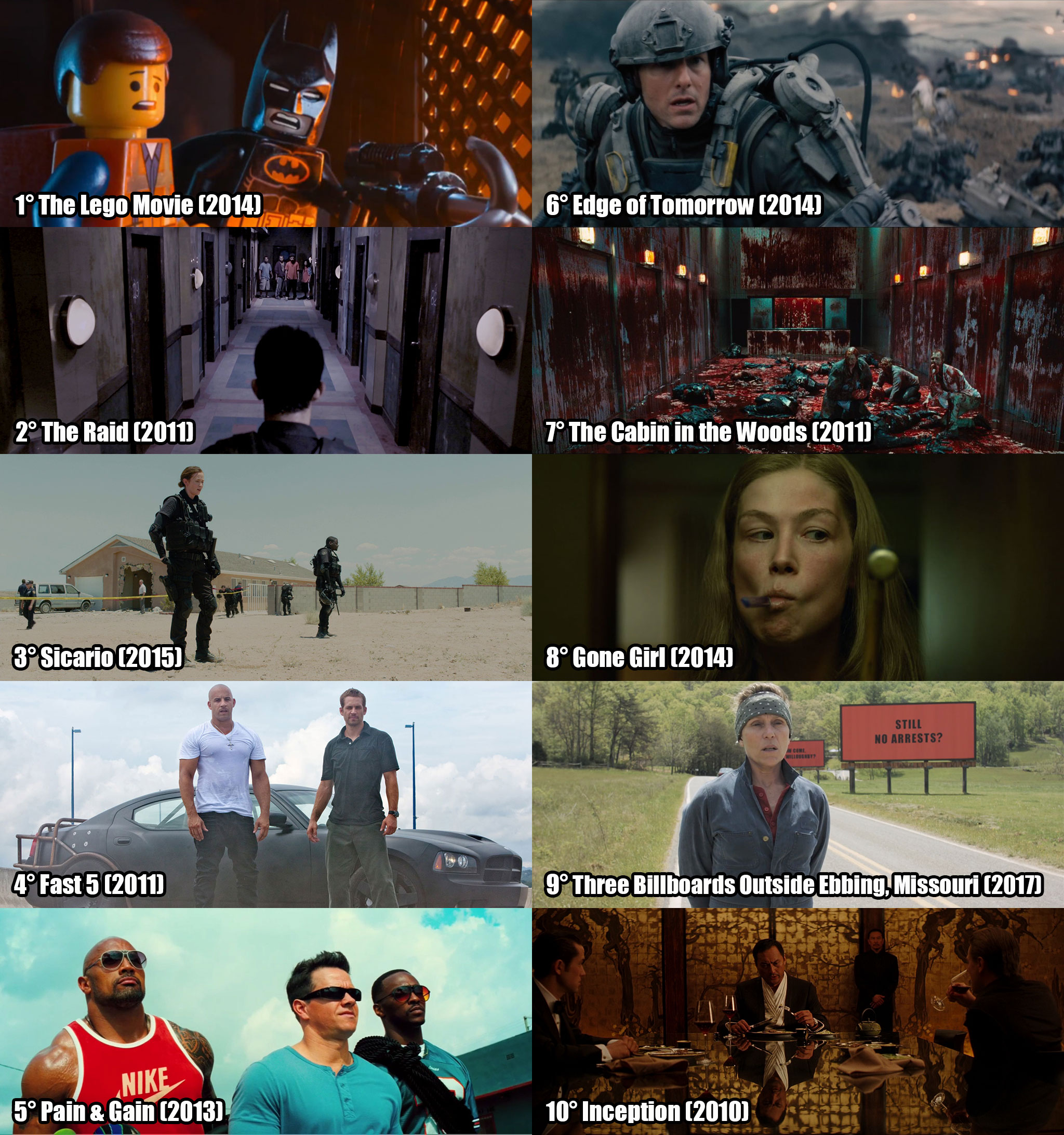Ad inizio giugno ho iniziato una conversazione via email con Mara, autrice ed editrice prima di Serialmente e ora di playermagazine, nonché persona particolarmente attiva nella lotta per i diritti delle donne e per la parità di genere. Mi capita spesso di litigare confrontarmi con lei su twitter, ma in questa occasione cercavo un dialogo libero da limiti di caratteri e lei è stata molto disponibile nel prestarsi a questa chiacchierata, cosa per cui la ringrazio molto.
Io sono quello che scrive in corsivo, che non può capire in quanto uomo ed il cui pensiero è irrilevante.
Lei è quella che scrive in grassetto e che parte per la tangente.
Ne è uscita una sorta di intervista certamente più lunga del previsto, ma a mio avviso interessante.
Ah sì, l’argomento è: le foto del cazzo in chat.
Il punto di partenza per me è questo: la pratica del mandare una foto del proprio cazzo in chat come “door opener” di relazioni che nascono online è diffusa. Tutti sanno che è qualcosa che succede, nel mio intorno digitale se ne parla spesso e anche nella mia vita reale, dove frequento persone che non hanno la mia stessa presenza online, l’argomento è sdoganato. Come a dire: esiste un fenomeno di costume che prevede l’iniziare una conversazione mandando all’interlocutrice la foto del cazzo. Se siamo arrivati a questo livello di diffusione del concetto significa che è davvero qualcosa di molto comune nella vita quotidiana delle persone. La mia logica ha quindi tirato due somme: se tutti conoscono il fenomeno vuol dire che ha attecchito, se ha attecchito vuol dire che funziona. Perché, prova a pensarci, lo scopo finale di questa cosa è scopare, giusto? Non ha altre implicazioni. Non c’è alcun ritorno per chi invia la foto se non il portarsi a casa una scopata. Lo fai una volta perché tuo cugino ti ha detto che è una strategia sicura, magari, ma se dopo tre tentativi non hai risultati o sei davvero orgoglioso oltre misura dell’aspetto del tuo uccello e valuti che continuare a spammarlo in giro valga il non scopare, oppure passi ad altro. Credo. Non so dirti il rate di successo, è probabile sia influenzato da mille variabili, ma di certo se nessuno avesse mai scopato grazie alla foto del cazzo in chat, Manq, utente social maschio che non è tendenzialmente bersaglio di questo tipo di messaggi, non ne saprebbe niente.
La prima domanda quindi, se vuoi anche per metterti a tuo agio, è: hai mai ricevuto cazzi in chat? SCHERZO. Non è una cosa che voglio sapere.
Per iniziare vorrei chiederti se hai la mia stessa percezione, ovvero di un fenomeno reale e diffuso, o se credi che sia legato 80% ad una certa narrazione maschile che per qualche ragione si bulla di azioni che poi in realtà non compie e 20% a reali disagiati che mandano la foto del cazzo anche se non porta da nessuna parte. Immagino che per una donna lo scenario possa anche essere molto diverso, quindi prima definiamo il campo da gioco se ti va.
Ecco, nel tweet parlavi di “statistiche” e di un “rate di successo” evidentemente incoraggiante al reitero della pratica, ma a conti fatti non stiamo parlando di numeri rilevati statisticamente ma della tua percezione all’interno della tua bolla che – naturalmente – è ben diversa dalla mia che infatti smentisce la tua di realtà. Prima di addentrarmi nella questione vera e propria, però, anch’io vorrei farti una domanda e chiederti se nella tua esperienza, diretta o indiretta, per un uomo l’arrivo non richiesto di foto esplicite è motivo di orgoglio ed entusiasmo, oppure è causa di disagio: ti è mai capitato di discutere con o di uomini che si sono sentiti offesi, mortificati, o infastiditi dall’arrivo non richiesto di particolari anatomici femminili? E se sei incappato in questa situazione la risposta circostante, soprattutto maschile, è stata di comprensione o dileggio?
Prevedo che per gli uomini non solo non sia un problema ricevere foto hot, seppure non richieste, ma anche motivo di vanto e purtroppo l’universo maschile è portato a prendere sé stesso e le proprie reazioni quale metro di misurazione da applicarsi a chiunque altr*.
Il fatto che esista tutto un mondo di donne che stigmatizza come inopportuno, mortificante, fin anche allarmante, il ritrovarsi email e dm con soggetti non richiesti dovrebbe far capire che è molto più comune che la destinataria blocchi il tipo che invia, piuttosto che gli accordi un appuntamento. Anche ammettendo che ci sia qualcuno a cui sia andata effettivamente bene (il “success rate” di cui parli) non dice nulla di quante volte la pratica debba essere reiterata per produrre frutti: è verosimile che all’invio delle tue pudenda, prima ancora di un ciao, ci sia subito una risposta positiva? Direi proprio di no, così come avviene per un qualsiasi altro tipo di approccio dal complimento al bar, a quello per strada, alla battuta a una festa [rassegnatevi: non esiste una tecnica infallibile]. Prima di arrivare al punto in cui la domanda si incontra con un’offerta bisogna tentare, quindi un tipo che verosimilmente ti dice di aver avuto di recente tre incontri con questa modalità ha probabilmente inviato un centinaio di foto a un centinaio di donne che in prevalenza si saranno offese, risentite, infastidite, ma in questi casi conta il risultato da esibire e tre donne a cui è andata bene questa modalità di incontro diventano facilmente lo standard a scapito di 97 a cui è stata rovinata la giornata.
Poi, sostenere che se l’invio della dick pick continua a essere pratica diffusa – numeri? – è perché funziona, significa anche dimenticare di quanto e come gli uomini siano abituati a fare quello che vogliono, o peggio continuino nel prodursi in quello che ritengono un esercizio di un loro diritto, nonostante venga loro spiegato che no, non è così. Vedi banalmente l’apprezzamento per strada, da anni viene detto che la catcall è offensiva e irritante ma pare che gli uomini continuino come fosse un loro diritto inalienabile. Ti prevengo: sì ci sono alcune donne a cui l’apprezzamento per strada aumenta l’autostima, questo perché il maschilismo non è genetico ma un costrutto sociale che non risparmia le stesse donne.
Hai messo un bel po’ di carne al fuoco, vediamo se riesco a commentare tutto con un minimo di ordine e senza perdermi nulla.
Dici che la mia realtà è diversa dalla tua, ma poi dici che effettivamente le dick pic sono una cosa reale, che effettivamente arriva, quindi settiamoci su questo dato: non parliamo di una leggenda metropolitana, ma di un fenomeno esistente. Che è la stessa realtà che vivo io, l’ipotesi su cui si fonda il ragionamento. Quel che per te è diversa è la percezione che io (uomo) e tu (donna) abbiamo del fenomeno, ma anche qui mi stai facendo più che altro un processo alle intenzioni. Chiarisco: la mia opinione sulla foto del cazzo come primo step comunicativo è che sia una roba completamente senza senso. Lo sarebbe anche a parti inverse, ovviamente. Se una tipa come prima cosa mi spedisse la foto delle tette la bollerei come una matta. E’ vero, probabilmente io non mi sentirei offeso o molestato dalla cosa perché parto da una posizione sociale ben diversa, ma penso che parte del problema sia proprio lì. Ci arrivo dopo, spero.
Quello che non mi torna è la tua certezza assoluta sul fatto che la maggior parte delle donne blocchi il tipo che gli manda il cazzo in chat e che il rapporto stia effettivamente di 97 cazzi mandati a vuoto contro 3 cazzi a bersaglio. Per me è un discorso illogico: così fosse non credo davvero ne staremmo parlando. E’ più probabile la verità stia in mezzo: quel tipo di approccio paga, in qualche modo, ma è difficile stimare quanto perché:
– una donna non può permettersi di dire “sì guarda, io se ricevo un cazzo in chat sono incuriosita” per evidenti problemi derivati, quelli sì, da secoli di cultura maschilista e repressiva (quindi cattolica).
– è ampiamente possibile il fenomeno sia partito da un portale dedicato a scopare (che so, Tinder) e che lì avesse magari un certo “success rate” che ha convinto i minus habens a sdoganarlo in ogni altro contesto. Perché un cazzo in chat su Tinder non è un cazzo in chat su LinkedIn. E non sto dicendo che su Tinder vada bene, attenzione, sto dicendo che capirei se su Tinder in qualche modo pagasse.
In queste discussioni tendenzialmente finisco a prendermi del maschilista (beh, lo sei, starai pensando. In realtà non credo, ma non sono qui per convincere nessuno.), forse è perché trovo superfluo dover precisare che nessuno dovrebbe sentirsi oggetto di attenzioni manifestate in modi che mettano a disagio. So che non è per niente scontato rendersi conto di quanto la realtà sia diversa da questo presupposto, però penso sempre di non dovermi far carico di tutti i malcostumi del mondo maschile semplicemente perché sono nato uomo. Quindi quando dici che ricevere la foto di un cazzo può mettere a disagio una ragazza io lo capisco, quando dici che gli uomini si arrogano il diritto di tenere atteggiamenti fastidiosi impunemente pure. Il fatto ci possa essere qualche donna, poche o tante non conta, che da quegli atteggiamenti non è turbata non giustifica l’estenderli a tutte? Agree.
Spero sia quindi chiaro che la mia qui non è una sorta di apologia del cazzo in chat, non cerco un contraddittorio di questo tipo. Io voglio capire come ci si possa essere arrivati. Prendo il tuo parallelismo perché me lo ha fatto anche un’altra ragazza su twitter: la catcall. Per me i due fenomeni non sono per nulla accomunabili.
Fischiare o fare commenti ad una ragazza per strada non è una tecnica di rimorchio. E’ una manifestazione di machismo che l’uomo usa per fare mostra di sé, spesso con altri uomini. E’ questione di branco o comunque di autodeterminazione. Nessun uomo fischia per strada sperando di ingraziarsi la vittima.
Il cazzo in chat è tutto un altro sport. E’ una questione privata, non c’è ritorno. Se stai cercando di scopare, fai le mosse che pensi ti portino a scopare. Se hai 100 donne e mandando il cazzo sai che te ne bruci 97, il cazzo non lo mandi.
Tu credi che oggi una ragazza possa dire: “A me piace ricevere cazzi in chat”?
Cito:
“La mia logica ha quindi tirato due somme” […] Non so dirti il rate di successo […] ma di certo se nessuno avesse mai scopato grazie alla foto del cazzo in chat, Manq, utente social maschio che non è tendenzialmente bersaglio di questo tipo di messaggi, non ne saprebbe niente.”
Ripartiamo da qui. La tua percezione, la tua bolla, la tua realtà di maschio etero. Vedi bene che alla tua base di partenza “io Manq utente medio non se saprei nulla se non fosse vero” potrebbe corrispondere un “Io Mara utente media non ne ho mai sentito parlare come di tecnica efficace” e le due percezioni si annullerebbero senza numeri, statistiche, ricerche a suffragare la percezione dell’una o l’altra bolla. Dal tuo tweet iniziale dicendo “statisticamente” ti avevo preso alla lettera, pensavo che effettivamente avessi letto di qualche ricerca sull’argomento ma qui siamo nel campo di “la mia esperienza”.
Ma, prima di proseguire, metto prima i puntini sulle i. Sì, sei maschilista e no, non lo dico come offesa, pregiudizio o preveggenza: semplicemente lo siamo tutti, donne incluse, perché siamo stati educati e cresciuti in una cultura maschilista e sessista per liberarsi della quale serve fatica, impegno, un’attenzione costante e una rinuncia, da parte degli uomini, a privilegi che non sono altro che soprusi socialmente accettati, e mi riferisco anche agli atteggiamenti più banali e scontati. Precisazione non necessariamente rivolta a te: rispettare le donne, riconoscere i loro diritti, essere per il consenso, essere contro la violenza ed essere a favore di un trattamento economico equo, è l’ABC della convivenza civile, nessuna medaglia al valore se credi in tutto questo. Un po’ come un genitore che dice “provvedo ai miei figli e non li picchio mai”: ci mancherebbe altro, è il minimo sindacale per essere genitori.
Quando scrivi “però penso sempre di non dovermi far carico di tutti i malcostumi del mondo maschile semplicemente perché sono nato uomo” confondi la colpa con la responsabilità: non è colpa tua se la situazione è quella che è, ma diventa una tua responsabilità continuare o meno a mettere in atto comportamenti che perpetuino lo status quo perché, come dicevo più su, essere contro la violenza, a favore del consenso ecc, non è sufficiente, bisogna che gli uomini rinuncino a quello che credono sia loro dovuto e cambino sistema di pensiero.
E qui mi ricollego al discorso principale.
Con l’esempio della catcall non ho voluto equiparare una presunta tecnica di rimorchio, l’invio della dick pic, ai fischi e lazzi per strada, ma mi è servito per sottolineare quanto poco agli uomini importi della reazione delle donne: da anni, ormai, agli uomini viene detto e ribadito che quella è una pratica indesiderata, ma loro continuano perché non ci vedono nulla di sbagliato, e se va bene a loro questo è tutto quello che vogliono sapere, e anzi sono convinti che alle donne piaccia anche se fanno finta di no.
Quindi sì, non ho mai negato che ci sia una diffusa pratica di invio di quel tipo di foto ma nego che possa essere una pratica che porta i propri frutti su una scala tale da far diventare il fatto una tecnica efficace per racimolare una serata di sesso. Chiarisco ulteriormente, non sto parlando di due che si messaggiano, si “piacciono” e da lì si passa al sexting: quando c’è reciprocità non esiste discussione.
Ma visto che parliamo anche di strutture di pensiero diverse e spesso opposte, prova a condurre un piccolo sondaggio tra gli uomini che cercano di portare a casa un paio d’ore di sesso e chiedi loro: se inviando a 100 sconosciute una foto del tuo pene, 97 si risentono, ma 3 sono a colpo sicuro, ti lanceresti? E vedi cosa ti rispondono. Malignamente, per me, per molti la risposta sarebbe “Sono carine queste tre?”. Seppure.
Ma ora parliamo di un po’ di numeri.
L’invio delle dp presuppone che l’uomo in questione sappia cos’è il consenso, e sappia distinguere una molestia da un comportamento considerato sessualmente eccitante. E non è proprio così. Se questa pratica fosse davvero conosciuta e sdoganata questi numeri direbbero qualcos’altro. (Link)
“Women also say they are not asking for these pictures. Only 11 percent of women overall say they have asked to be sent a dick pic. That number increases to 23 percent among millennial women. However, of the 53 percent of millennial women who have received a dick pick, more than three in four (78 percent) say those pictures were unsolicited.”
Ma la parte interessante è questa, la percezione di cui parlavamo prima e di cosa gli uomini pensano che una donna pensi:
“This miscommunication about nude photos also extends to the ways women perceive those pictures and how men think women perceive them. When given a range of adjective most millennial women picked the words “gross” (49 percent), “stupid” (48 percent), and “sad” (24 percent). When millennial men were asked how they think women would describe dick pics, the number one answer was “gross” at 32 percent. However, the second highest adjective chosen was “sexy” at 30 percent. Only 17 percent of millennial women described dick pics as “sexy.” The same was true for just 9 percent of women overall”
Infine:
“Previous research has found young men are less aware about what constitutes sexual assault. A survey by the National Sexual Violence Resource Center found that young men are less likely than women to view things like non-consensual voyeurism, sexual coercion, and verbal harassment as forms of sexual assault. This is especially troubling given the number of young men who are sending dick pics and the even greater number of women who are not asking for them.”
Quindi gli uomini non solo tendono a non sapere cosa è molestia e cosa no, ma pensano che alle donne piaccia e – aggiungo io – semplicemente perché piace a loro.
Quindi in questo contesto desolante mi pare inverosimile che ci siano frotte di ragazzi o uomini che con l’invio del proprio pene rimedino una serata a colpo sicuro.
Temo ci sia tra noi un gap comunicativo, ma forse non ha tanto senso insistere oltre su quel che è percezione e quel che è assodato perché se non sono riuscito a spiegarmi fino ad ora, non credo di poter migliorare.
Mi piace la parte sui dati e ci vorrei tornare sopra, partendo però da quanto scrivi nel paragrafo prima relativo al nostro essere maschilisti come società, cosa su cui hai assolutamente ragione. Il punto che vale la pena forse analizzare è che la società maschilista è composta tanto da uomini, quanto da donne. Togliamo per un secondo l’uomo dall’equazione e concentriamoci sulle donne.
Vivere in una società radicalmente maschilista porta le donne a vivere male aspetti della sessualità che non andrebbero vissuti così. E lo capisco, perché non è facile smarcarsi da un giudizio costante e ossessivo che parte dall’aspetto e arriva agli atteggiamenti. Se me lo chiedi siamo in un momento brutto della storia in cui non vedo muovere grandi passi verso una reale emancipazione della donna, ma proviamo a dimostrare che così non è con battaglie che puntano molto più sul punire l’uomo che non sul mettere la donna nelle condizioni di non essere più vittima. Questa stortura, a mio avviso, genera mostri. Se non lavoriamo per togliere dalla testa delle donne 2000 anni di cultura cattolica in cui il sesso è peccato, vergogna o, nel migliore dei casi, qualcosa di bello SE fatto al momento giusto e con la persona giusta (ad insindacabile parere di terzi) non risolveremo mai il problema, ipoteticamente anche cancellando 2000 anni di cultura machista dalla testa degli uomini.
Sarò io che over semplifico, ma il mio mondo ideale non è quello dove nessuno manda foto di cazzi, ma quello in cui la foto di un cazzo non è che un selfie. Una parte anatomica che accomuna metà della popolazione del globo, magari non esteticamente splendida, ma certamente nulla che possa turbare, sconvolgere o far sentire una donna molestata. Cerca di capirmi qui, perché è importante: non voglio cambiare le donne per “scagionare” o “depenalizzare” certi atteggiamenti maschili. Credo tuttavia che in un mondo in cui tutti vivessimo con serenità e senza tabù la sessualità, metà degli atteggiamenti che oggi sono molestie (e lo sono, insindacabilmente, perché arrecano danno) non lo sarebbero più. Ripeto: non sto dicendo che mandare la foto del cazzo sia una cosa innocua di cui le donne fanno ingiustamente un problema, sto dicendo che è un problema e come tale va affrontato, ma che lo è anche a causa di un bias culturale che non riguarda chi manda la foto, ma chi la riceve. Spero sia chiaro il punto. La domanda, ora.
E’ possibile che i dati che citi, come l’esperienza diretta che hai parlando con altre donne, siano “fallati” dal fatto che, in merito a certi argomenti, semplicemente le donne non siano nella condizione di essere sincere? Non voglio ridurre tutto alla regola del 3 di American Pie, ma è un buon punto di partenza. Aggiungo, ritornando al discorso culturale, come ti poni rispetto al ragionamento che ho tentato di fare sul peso che una certa cultura ha sulla donna e sul concetto di molestia?
Quando dici “ma proviamo a dimostrare che così non è con battaglie che puntano molto più sul punire l’uomo che non sul mettere la donna nelle condizioni di non essere più vittima” incorri nel primo errore, quello di dividere il problema in due parti separate e caricare la donna dell’onere della prova: non funziona così. Il rapporto tra i generi è strutturato e solidificato in quello che è un rapporto tra oppresso e oppressore, ti sembrerà una esagerazione, ma è esattamente così. Appena fino al 1996 lo stupro in Italia, non nella Repubblica Centroafricana, era un reato contro la morale pubblica: culturalmente siamo andati poco più avanti.
Tutto il mondo è fatto a immagine e somiglianza del maschio bianco etero, incluse le più piccole faccende che riguardano le donne sono pensate e concepite in funzione dell’uomo. In queste condizioni è impossibile che le donne da sole decidano che “il sesso ci piace e non ce ne vergogniamo e vogliamo anche tatuarcelo e portarci a casa ogni sera uno diverso” e tutto è bene quel che finisce bene, perché dall’altra parte deve esserci una maturazione della cultura del consenso, di educazione sessuale che deve innanzi tutto essere educazione all’intimità, e un cambiamento radicale, profondo, epocale della cultura maschile altrimenti il tuo discorso si riduce esattamente a un mero tornaconto, avere una facilità di fare sesso sempre e ovunque e senza che l’uomo si metta in discussione.
Ma l’errore più comune e grave che commetti, tu come tanti altri, è considerare le problematiche femminili a compartimenti stagno: non funziona così, e la liberazione sessuale delle donne è inestricabile da quella economica: finché le donne non avranno diritto a pari trattamento salariale, trattamento equo sul lavoro e durante il lavoro, tutele in caso di maternità, finché le donne non potranno fare carriera in ogni singolo settore, sfondare il famigerato tetto di cristallo, guadagnare quanto gli uomini e avere le stesse identiche opportunità, la liberazione sessuale sarà impossibile perché sesso&potere sono indivisibili. Vuoi le donne sessualmente libere? Rinuncia ai tuoi privilegi, rinuncia alla tua posizione predominante all’interno della società. Altrimenti troppo comodo avere sesso facile e a portata di mano ma con gli uomini ancora in vantaggio anni luce in economia e lavoro. Esemplifico con il commento di un utente maschio trovato su Quora, il titolo di discussione è “Why aren’t women turned on by dick pics?“, intervengono sia uomini che donne e, stringendo, anche per un paio di donne che dicono di gradire, il punto è sempre lo stesso: consenso e contesto. Ma, a proposito di potere
Men are generally much bigger and stronger than women and often have a lot more social power. (…) Consequently, if a woman sends an unsolicited pussy pic to a guy, he doesn’t feel threatened because he knows he can easily dismiss her if he doesn’t want her. When a man sends an unsolicited dick pic to a woman, though, there’s a whole different power dynamic. The woman may feel threatened because she knows this man who keeps violating her by sending her pictures she doesn’t want could easily go a step further and have his way with her against her will if he wants to. (link)
Auspichi le donne libere che possano postare e ricevere allegramente nudi e dick pik senza lo stigma dell’essere una facile? Sii un alleato per le battaglie femministe sul lavoro, non puoi avere l’una senza l’altro. Desideri che tua figlia da grande possa vestirsi come le pare, tornare all’ora che preferisce, potersi scambiare selfie e foto scherzose delle mutandine con i draghi con compagni/e di classe senza essere bullizzata, poter prendere i mezzi pubblici senza che qualcuno le metta le mani addosso, avere 13 anni senza che i 40enni la guardino in spiaggia o all’uscita da scuola pensando “è già una donna…”, ecco battiti affinché da grande abbia le stesse identiche opportunità di lavoro, carriera e salario degli uomini senza che nessuno la faccia sentire in dovere di aderire a un modello estetico, o la giudichi da meno perché le donne sono inadeguate a ricoprire posizioni di comando, sono problematiche, emotive, fanno figli…
Ma tornando alla questione principale. Io ho inteso la tua posizione, tu dici “se gli uomini continuano a inviare dick pic vuol dire che il riscontro è positivo perché altrimenti non lo farebbero, converrebbe loro più non farlo che farlo“. Il fatto è che, al di fuori di un discorso di percezioni, Io non trovo alcun riscontro alla tua ipotesi, piuttosto articoli che puntano nella direzione opposta.
Ne linko uno in cui la giornalista che si è resa disponibile all’invio di dick pic, successivamente ha intervistato diversi uomini proprio per sapere se l’invio del loro pene sia mai stato determinante per concludere: la risposta è no, funziona solo se è già in atto una “conoscenza“. La giornalista conclude:
And another thing: of all the people I interviewed, not one had actually slept with a woman after sending an unsolicited dick pic. So there could be something in that for all you straight white men thinking about sending a dick pic. Maybe just don’t.(link)
L’articolo è però datato agosto 2017, due anni sono una piccola era su internet, magari qualcosa è cambiato.
Ho trovato altro materiale, ma tutto quello che c’è a proposito della dick pic come tecnica di rimorchio rimanda a molestie e consenso. Non ho trovato nulla che evidenzi un trend per il quale l’invio dei propri genitali faciliti in prima battuta un uomo. Ci sta che una donna non si senta di ammettere “sì, mi piace che mi si inviino nudi“, ma a questa donna che non si esprime corrisponde la mitomania da bar degli uomini che da sempre millantano conquiste solo immaginarie.
Per chiudere, una riflessione: facciamo conto che sia vero, inviare una dick pic è un approccio vincente, come concili questa pratica con il fatto che solo due mesi fa è stato votato l’emendamento di Boldrini a tutela delle donne vittime di cyberbullismo (e voglio vedere all’atto pratico se farà differenza)? Come possono tante donne gradire un comportamento dal quale allo stesso tempo non hanno i mezzi per difendersi quando non è richiesto?
E’ probabilmente vero che il comportamento e l’educazione femminile non può essere analizzata a compartimenti stagni e che sulla libertà sessuale pesa, in primo luogo, la mancata emancipazione economica della donna. Nella prima parte del tuo commento però fatico un po’ a seguirti, non perchè quel che dici sia sbagliato o non condivisibile, ma perchè mi sembra tu voglia un po’ troppo aprire il campo da gioco e non lo faccia sempre in modo “attinente“.
Commento la seconda parte quindi, provando a rispondere alla tua riflessione. Premessa: hai citato degli articoli che in pratica sostengono mandare dick pics sia inutile, ai fini di cui discutevamo. Per me la cosa non ha senso, ma non ha senso nemmeno mandare dick pics, quindi ecco, ci sta il mio presupposto fosse basato sul un metro di giudizio che evidentemente non è largamente condiviso nel mondo maschile (etero?). Siamo venuti a capo della domanda principale, quantomeno.
Ora, come possono le donne gradire qualcosa da cui però non possono difendersi? Qui per me torniamo al problema centrale: perchè dovrebbero “difendersi” dalla foto di un cazzo? Nell’articolo che citavi si dice:
“The woman may feel threatened because she knows this man who keeps violating her by sending her pictures she doesn’t want could easily go a step further”.
Io capisco il ragionamento e non mi permetto di dire sia infondato, ma ci sono dei dati a supporto di questa “paura“? Una correlazione tra foto di cazzi non gradite e effettivi “step further“? Perchè quel che cerco di dire dal principio (probabilmente male) è che una narrazione che sovraccarica comportamenti che abbiamo assodato essere fastidiosi e irrispettosi, di implicazioni violente a mio avviso non fa bene alla causa. E’ sacrosanto diritto della donna non ricevere foto non gradite di cazzi, ma non penso faccia bene averne paura. Non se non c’è un reale motivo per averne.
In altre parole, estremizzando giusto un po’ per darti l’appiglio a non seguire il discorso e partire per la tangente (I’m joking), non credi il tuo discorso sugli uomini come macro categoria assomigli ad un certo tipo di discorsi fatti sugli immigrati o i rom, come macro categorie?
Io vorrei essere stringata e rimanere sul punto della domanda, il problema è che è impossibile, ma non per le mie scarse doti di sintesi, semplicemente perché hai preso in esame un argomento che è interconnesso con un problema risultante da una cultura sociale, politica ed economica che dalla notte dei tempi opprime la donna: il patriarcato.
Tu dici:
“[..]comportamenti che abbiamo assodato essere fastidiosi e irrispettosi, di implicazioni violente a mio avviso non fa bene alla causa. E’ sacrosanto diritto della donna non ricevere foto non gradite di cazzi, ma non penso faccia bene averne paura.”
Ecco, quello che pensi tu è irrilevante, e quello che davvero non fa bene alla causa è che tanti uomini pensino di essere in diritto di avere un’opinione sul cosa e come una donna dovrebbe sentirsi in una posizione disagiata in cui è stata messa. La persona del commento di cui sopra ha intuito giusto: la donna atavicamente è stata delegittimata e privata di potere e nel momento in cui è oggetto di una molestia, oltre alla sgradevolezza dell’atto, c’è anche l’impotenza che deriva proprio dal sapere di non avere alcun potere, e di non avere i mezzi per rispondere adeguatamente, per esempio con una denuncia, se ritiene il caso. Se una donna sente la propria incolumità in pericolo, non conosco la sua storia, le sue esperienze, la sua situazione, e quindi di sicuro non mi sento di derubricare una paura a esagerazione: penso non dovrebbe farlo nessuno.
Ma se vuoi l’estrema sintesi: la liberazione sessuale delle donne è inscindibile dal potere economico, finché la donna non avrà pari opportunità di guadagnare, fare carriera, ricoprire incarichi di potere tanto quanto gli uomini, gli uomini vedranno sempre nelle donne un oggetto sessuale a disposizione, in ogni caso, una persona di rango inferiore.
“Non credi il tuo discorso sugli uomini come macro categoria assomigli ad un certo tipo di discorsi fatti sugli immigrati o i rom, come macro categorie?”
Non saprei, tu ritieni forse che gli afroamericani quando parlano di razzismo trattino i bianchi come macro categoria tipo i discorsi sugli immigrati o i rom? Bisognerebbe essere un afroamericano per saperlo.
Chiudo con un consiglio: Nanette di Hannah Gadsby, disponibile su Netflix, illuminante per la questione femminile.